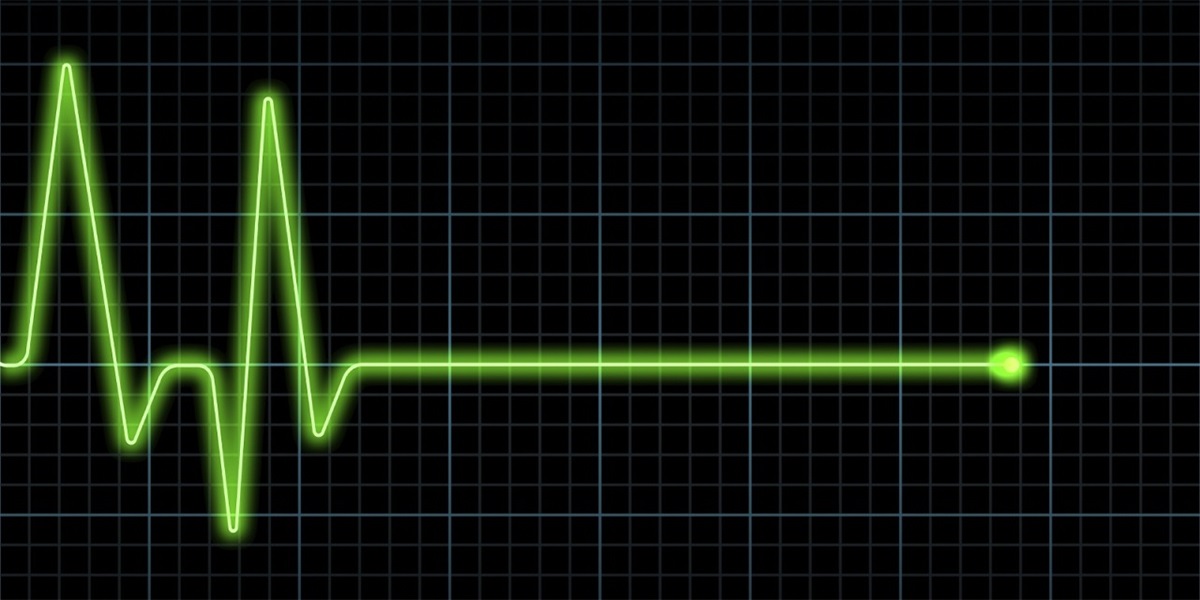Il dolore che si prova nel perdere un paziente
Purtroppo ci sono casi in cui la vita fugge via e le mani dei medici che provano a rianimare non riescono a trattenerla in un corpo troppo ferito, troppo ammalato. Si deve accettare anche questo, e non è facile, ma è dovere del medico non accanirsi, sapersi fermare quando non c’è più nulla da fare anche se questo provoca frustrazione e sconforto. Conosco bene questo sentimento, l’ho provato diverse volte e credo che sia una delle sensazioni più forti e difficili che un medico possa provare.
Era inverno ed ero arrivato da poco a Philadelphia per dirigere il centro trapianti della Thomas Jefferson University. Una notte venni chiamato per la disponibilità di un organo che poteva essere utilizzato per trapiantare di fegato un paziente in coma a cui non rimaneva più molto tempo a causa della cirrosi e di una grave infezione respiratoria. Il batterio che infettava i polmoni era difficile da combattere e rappresentava un ostacolo importante per il trapianto. Alfredo Rosero era un uomo di origini ispaniche, padre di un medico il quale, assieme alle sorelle e ad altri medici dell’ospedale suoi amici, insistette affinché si facesse un tentativo. Eseguii il trapianto di fegato: la mattina successiva Alfredo si svegliò e per un paio di settimane tutto proseguì tranquillamente.
Una notte le condizioni di Alfredo improvvisamente peggiorarono, dovettero intubarlo e riportarlo in terapia intensiva. Diedi le mie disposizioni: Full code, ovvero mettere in atto ogni possibile risorsa e non lasciare nulla di intentato.
Iniziammo una lotta senza sosta contro quel batterio che voleva portarsi via Alfredo. Molte persone iniziarono a ripetermi: «Lascialo andare». Io li ascoltavo e ogni tanto pensavo che avessero ragione, che forse stavo andando oltre il limite che mi era concesso per tentare di aiutare quell’uomo. Ma poi Alfredo si risvegliava e rispondeva con gli occhi alle mie domande e non riuscivo ad arrendermi. Un giorno, rientrato in ospedale dopo un breve viaggio all’estero, il mio principale collaboratore entrò nell’ufficio: «Alfredo è morto», mi disse senza fare alcun commento, e uscì. Non chiesi nulla. Tornato a casa, di notte, accesi il computer e mi misi a leggere la cartella clinica con le informazioni sulle ultime ore di vita di Alfredo: l’infezione aveva ripreso vigore per l’ennesima volta, il mio ordine Full code di un anno prima era stato modificato in Do not resuscitate. Ad Alfredo era stato dato il permesso di andarsene.
Durante gli anni in cui lavoravo a Pittsburgh nel reparto di terapia intensiva del centro trapianti, una notte arrivò la segnalazione di un organo, un fegato, che sarebbe stato adatto per un trapianto pediatrico. Pensai subito a Francesca, una bambina di sei anni, italiana, che aveva già subito tre trapianti di fegato ma che in quel momento stava di nuovo male e aveva bisogno di un nuovo organo perché il suo non funzionava più a causa di un rigetto cronico. Chiamami in Italia i genitori di Francesca e ci attivammo per il trasporto della piccola paziente negli Stati Uniti, con un aereo messo a disposizione dall’aeronautica militare italiana. Andai ad aspettare il loro arrivo all’aeroporto e mi commosse il gesto di rispetto e di augurio che l’equipaggio militare italiano volle dedicare a quella bambina incerta nei suoi passi, schierandosi in picchetto d’onore e saluto militare sulla pista d’atterraggio all’uscita dell’aereo.
Non c’era più tempo, dovevamo correre perché l’organo, che era stato prelevato alcune ora prima, rischiava di deteriorarsi se non fosse stato trapiantato al più presto. Arrivati in sala operatoria tutto era già pronto e l’intervento iniziò senza complicazioni. Riuscimmo a sostituire il fegato malato con quello sano e, una volta constatata la funzionalità del nuovo organo, finalmente facemmo una pausa prima di concludere il trapianto. Ricordo che stavo bevendo una tazza di caffè nella stanza dei medici quando un’infermiera venne a chiamarmi, c’era qualche cosa che non andava. Francesca non riuscì a sopportare il peso di un ennesimo intervento chirurgico lungo e complesso, il suo cuore cedette e tutti i nostri sforzi andarono persi. Il colloquio con la famiglia fu così drammatico e commovente che anche noi medici non riuscimmo a trattenere le lacrime. Pur con la consapevolezza che avevamo tentato il tutto per tutto per riuscire a darle una speranza, nulla poteva essere di consolazione di fronte al fatto che non avevamo più Francesca.
La mattina successiva andai in ospedale ma dovetti andare via dopo pochi minuti. Il dolore che provavo, lo sconforto, la frustrazione erano troppo forti e sentivo che non avrei retto un altro caso così e che non sarei stato di aiuto a nessuno in queste condizioni. Mi presi un periodo di pausa in cui mi dedicai a un progetto di ricerca.
Ogni medico, infermiere, e chiunque vive a contatto con gli ammalati, deve stare attento a non superare la soglia che gli permette di convivere con la sofferenza e il dolore altrui che inevitabilmente diventa anche proprio.
 06.60301809
06.60301809